Le storie hanno sempre avuto un potere speciale: sono strumenti che possono incidere profondamente sulla realtà, cambiandola. Sin dai tempi antichi, scrivere è stato un atto intrinsecamente rivoluzionario. Non è un caso che proprio le storie, con la loro capacità di suscitare empatia e creare legami tra le persone, siano state sfruttate per tramandare insegnamenti, promuovere idee, commercializzare prodotti e raccogliere sostegno attorno a cause.
L’idea che una storia possa stimolare il cambiamento non è certo una scoperta recente. Ma come possiamo fare in modo che questa possibilità diventi un’azione intenzionale? Scrivere con uno scopo ben definito – o meglio, con un purpose – può trasformarsi in una pratica collettiva e consapevole, un mezzo per restituire alla società il potere di decidere la propria direzione, di esprimere il dissenso, e di influenzare i processi decisionali.
Chi scrive per il cambiamento diventa un facilitatore, un raccoglitore e un curatore, con l’obiettivo di dare vita a una narrazione che non racchiuda solo una storia, ma molte. Scrivere diventa così un atto creativo collettivo e di immaginazione condivisa, un modo per dare forma all’identità, ai miti e ai valori di una comunità o di più comunità, portando alla luce questioni e prospettive che spesso restano escluse dalle narrazioni dominanti.
L’ospite di oggi qui su BUNS è Nicole Romanelli, una creativa che ha scelto di mettere il proprio talento al servizio dell’impatto sociale. Da sempre, usa la scrittura, la comunicazione e la creatività con un intento preciso: innescare un cambiamento reale. Ha lavorato in una vasta gamma di ambiti, dall’advocacy al fundraising, dal community organizing alla formazione, contribuendo a campagne che hanno influenzato la legislazione, alimentato movimenti sociali e mobilitato persone per sostenere cause importanti.
Nel 2018 ha co-fondato il collettivo Creative Fighters, dando vita alla campagna indipendente Solo In Cartolina, a supporto delle ONG impegnate nel Mediterraneo, e ideando un modello innovativo di attivismo creativo chiamato crowd campaigning. Nel suo percorso educativo, ha insegnato in istituti prestigiosi come lo IAAD, il Quasar Institute for Advanced Design e lo IED di Roma, dove ha anche lanciato il primo corso italiano di Brand Activism, esplorando il legame tra brand e impatto sociale con un approccio aperto e collaborativo.
Oggi lavora da BCG Brighthouse, società internazionale di consulenza creativa specializzata in purpose consulting, comunicazione strategica e cambiamento organizzativo, continuando il suo impegno per un mondo più consapevole e responsabile.
Nicole, ti va di raccontarci qual è il segreto per trasformare una storia in una spinta concreta per il cambiamento? In un mondo dove siamo inondati da messaggi di ogni tipo, come fai a creare qualcosa che colpisca davvero?
Le storie che generano cambiamento non devono solo essere scritte o raccontate: devono essere praticate. Questo cambio di paradigma ci sposta da un approccio autoriale a una dimensione quasi cosmologica di creazione del mondo, con un impatto pratico che rivoluziona completamente il concetto tradizionale di scrittura.
Le storie per il cambiamento sono storie che raccontano altre storie e, in questo senso, sono multidimensionali. La prima dimensione è la storia del sé, che ci riconnette con il motivo per cui ci sta a cuore una determinata causa. La seconda dimensione è la storia del noi, che ci ricorda che non siamo sole di fronte a una sfida, dando vita a quella che, in gergo tecnico, si chiama constituency, ossia un’entità rappresentata o considerata unitaria per scopi politici, organizzativi o sociali. Infine, c’è la storia dell’adesso, che ci informa sull’urgenza e sulla strategia da attuare, abilitando la nostra agency, ovvero la nostra capacità di scegliere e agire.
Queste storie si fondano su valori condivisi e devono essere coerenti tra loro e con chi le racconta. Troppo spesso però percepiamo un disallineamento tra sé, noi e adesso. Facciamo un esempio: come può generare cambiamento un discorso, magari anche ben scritto, che prova a denunciare il divario di genere sugli stipendi se declamato da un CEO uomo, bianco e di mezza età? Perché per lui dovrebbe essere importante? L’agency di quale “noi” potrebbe abilitare? Perché dovrebbe essere urgente?
Per questo le storie di cambiamento non si scrivono: si co-progettano. Chi crea queste storie non è uno scrittore nel senso tradizionale del termine, ma un facilitatore che porta più voci a convergere. Solo in questo modo sarà possibile creare una connessione emotiva mostrando vulnerabilità e speranza al fine di far emergere una narrativa condivisa e orientata allo stesso scopo, ma allo stesso tempo declinabile a traducibile nelle singole storie di tutti i giorni.
Questa rigenerazione continua della narrativa, che ci riporta quasi all’origine delle storie e alla loro tradizione orale, fa sì che le storie per il cambiamento accadano mentre vengono raccontate. Se siamo fortunati, quella narrativa condivisa, declinata su molti sé, inizierà a creare una crepa nello status quo, trasformandosi in contro-narrazione e poi in narrazione, per essere nuovamente messa in discussione in un processo ciclico. Perché, si sa, l’unica cosa certa è il cambiamento.
Cos’è, esattamente, il crowd campaigning? Come funziona questo metodo e cosa lo rende unico rispetto alle forme classiche di attivismo?
Il termine crowd campaigning è un neologismo nato all’interno del collettivo di cui faccio parte, le Creative Fighters, per descrivere l’approccio della nostra prima campagna, Solo In Cartolina. Tutto è iniziato come risposta a una dichiarazione dell’allora ministro degli interni Matteo Salvini: “Le ONG quest’anno vedranno l’Italia solo in cartolina.”
Abbiamo lanciato un appello chiedendo a illustratrici, artiste e designer di tutta Italia di inviarci la grafica di una cartolina dalle spiagge italiane per denunciare le morti nel Mediterraneo. L’obiettivo era chiaro: mobilitare la comunità creativa per sostenere le attività di salvataggio in mare consegnando 10.000 cartoline di denuncia al Viminale.
Da allora, questo approccio è diventato il nostro modo di fare attivismo: co-progettare campagne radicate in una narrativa condivisa, a cui diverse comunità creative possono prendere parte attivandosi. Non è solo crowd campaigning, ma anche crowd creativity dove la creatività diventa uno strumento di lotta con l’obiettivo di riportare l’attivismo a una dimensione collettiva, e non individuale o performativa.
Il concetto di crowd campaigning tenta anche di superare il classico approccio verticale, estrattivo e competitivo, tipico dell’industria creativa e pubblicitaria, creando uno spazio di coraggio dove ognuno può trovare il proprio posto sperimentando modalità orizzontali, collaborative e decentralizzate. Siamo crowd and loud, ma anche senza capo né coda.
Nel tempo, questo approccio è diventato uno dei valori più distintivi del nostro collettivo, e il crowd campaigning è entrato a far parte del nostro lessico familiare. Perché troppo spesso dimentichiamo che generare cambiamento significa abilitare l’agency delle altre persone e non la propria.
Hai lanciato il primo corso di Brand Activism in Italia – praticamente un nuovo “sport” per chi si occupa di branding. Come hai visto evolversi il rapporto tra brand e cause sociali? Pensi che il pubblico sia sempre più affezionato a queste iniziative, o c’è il rischio di “indigestione” da parte delle persone?
Il legame tra brand e cause sociali è meno romantico di quanto si immagini. Ho iniziato a fare attivismo quando essere attivisti era considerato da sfigati e non saprei dire esattamente quando le cause sociali hanno iniziato a invadere i nostri feed, trasformandosi in un trend. Oggi fanno parte delle strategie di marketing come cavallo di troia per i consumatori definiti più consapevoli o attenti a determinati valori.
Si dice spesso che è più facile immaginare la fine del mondo che quella del capitalismo. Non sorprende, quindi, che il brand activism, concettualizzato da Kotler e Sarkar, sia visto come un tentativo di dirottare il capitalismo verso una forma più responsabile: lo stakeholder capitalism, dove ogni impresa persegue un purpose, inteso come ragion d’essere, più alto ed è orientato al bene comune di tutti gli attori coinvolti, dagli investitori, ai lavoratori, ai clienti, fino ai territori impattati dalla produzione.
I grandi brand, grazie al loro potere mediatico, hanno sempre avuto un ruolo cruciale nella costruzione delle narrazioni – o contronarrazioni – che definiscono la realtà. Ma il brand activism non ha a che fare con la comunicazione ma con la struttura organizzativa. Un esempio positivo si verifica quando un brand, parlando di empowerment di persone con disabilità nello sport, non si limita a farlo nei suoi spot pubblicitari, ma aumenta anche la loro rappresentanza tra i dipendenti e i dirigenti. Questa coerenza tra comunicazione esterna e politiche interne misura l’impegno reale di un brand e può ridurre il rischio di accuse di washing.
Tuttavia, il vero rischio non è il fatto che i brand decidano di supportare una causa e a che livello – decisione che comunque nasce da strategie mirate ad aumentare vendite e profitti – ma il momento in cui si posizionano come piattaforme di cambiamento attuando un vero e proprio processo di mercificazione delle cause. In questo caso non vedo un rischio di indigestione, ma di manipolazione.
Ci racconteresti un episodio che per te rappresenta il vero senso di “scrivere per il cambiamento”? Quel momento in cui hai pensato: “Ecco, è per questo che faccio tutto questo!”
Sono stata fortunata e ho vissuto molti momenti in cui ho pensato: “Ecco, è per questo che faccio tutto questo!”. Ma, essendo nostalgica per indole, cerco sempre di spronarmi a rimanere focalizzata sul qui e ora. In questo momento, non potrei essere più felice dell’azione che abbiamo progettato con le Creative Fighters per la campagna europea My Voice, My Choice.
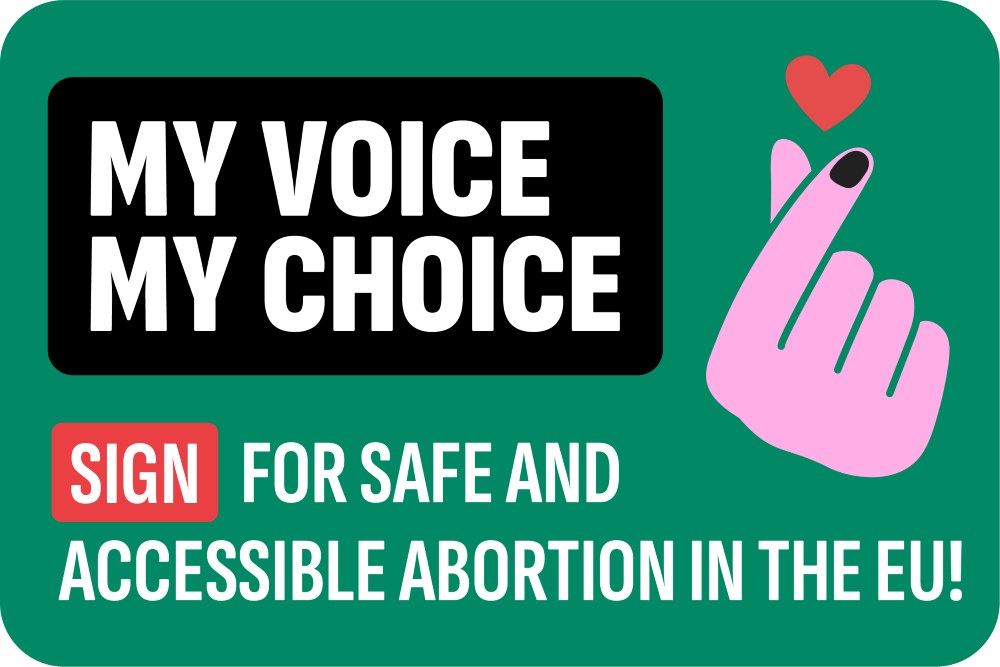
La campagna My Voice, My Choice è un movimento europeo che punta a garantire l’accesso sicuro e legale all’aborto in tutta l’Unione Europea. Lanciata lo scorso aprile, grazie allo sforzo collettivo di oltre 300 organizzazioni, è diventata l’ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) più veloce di sempre. Al momento in cui parlo, abbiamo superato le 900.000 firme e puntiamo a raggiungere il milione entro fine anno.
In Europa, l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, IGV, resta un diritto spesso negato. In molti Paesi, l’aborto è ancora proibito, costoso o di difficile accesso a causa di ostacoli burocratici, culturali e morali. Anche in Italia, nonostante sia formalmente garantito, l’IVG si scontra con la realtà di medici obiettori, consultori inefficienti e un sistema culturale patriarcale che continua a stigmatizzare le scelte delle donne.
Per sostenere la campagna, in occasione del 25 novembre, abbiamo lanciato il PassAborto, un documento simbolico che rappresenta il bisogno concreto di tutelare questo diritto fondamentale. Lo abbiamo condiviso, timbrato e portato nelle piazze di tutta Italia durante le manifestazioni, chiedendo di garantire la libertà di scelta, ovunque questa scelta ci porti.
Essere presenti non solo con le parole, ma con i nostri corpi. Non solo come individui, ma come collettività. Esserci per non scegliere la paura e l’isolamento, ma la solidarietà e la speranza. Ed è in momenti come questi che mi ricordo perché faccio quello che faccio. A proposito: se volete, potete firmare qui.
E infine, sei anche insegnante e formi giovani creativi per l’impatto sociale. Qual è il consiglio che dai sempre ai ragazzi? E cosa rispondi a quelli che vogliono cambiare il mondo ma non sanno proprio da dove partire?
Il nostro non è un paese per giovani. Il solo fatto di esserlo, in questo momento storico, rappresenta un’enorme sfida. D’altra parte, per quanto possa sembrare una concezione stereotipata, da sempre nella storia sono stati i giovani a far rivoluzioni. Chi ha più futuro davanti a sé è solitamente più propenso a voler cambiare il presente, anche perché ha più tempo e risorse emotive da investire.
Detto questo, negli ultimi decenni abbiamo assistito a una narrazione opposta, che ha generato immobilismo e impotenza, spingendo le nuove generazioni verso l’isolamento e la paura. Dal G8 di Genova, alle condanne degli attivisti per il clima, fino alle recenti modifiche del DDL sicurezza: ogni visione alternativa del mondo viene e verrà sempre più ostacolata. Ma chissene frega.
Per me provare a cambiare le cose significa prima di tutto dire di no e prendere atto che una determinata cosa, così com’è, non va più bene per te e per gli altri. Imparare a dire di no è primo passo per generare un cambiamento nella propria vita e nel mondo, sapendo che per cambiare bisogna lasciar andare qualcosa per fare spazio a qualcos’altro. Mostrare problemi che gli altri non vogliono vedere. Perdere follower, non aumentarli.
L’importante è avere la giusta compagnia e rimanere presi bene, anche quando ci troviamo ad avere a che fare con cose che ci fanno prendere male. Non credo più nei purgatori e nel sacrificio, ma questo i miei studenti e credo le generazioni più giovani in generale l’hanno capito molto meglio e molto prima di me.








